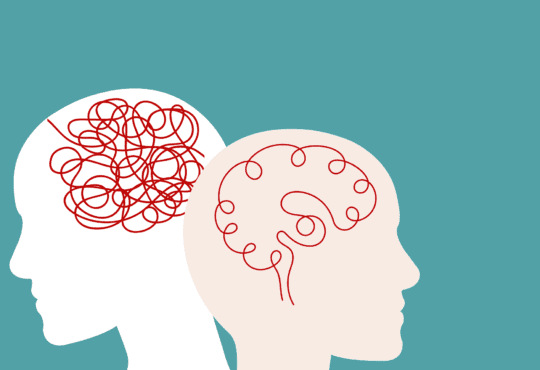Sii fedele ai tuoi sogni
Be faithful to your dreams
Avete mai avuto un sogno? Uno di quelli che vi assilla a ogni ora del giorno e non vi fa dormire la notte. Di quelli a cui dedicate ogni frammento del vostro essere, ogni sforzo del quotidiano. Che alimentano la vostra fame quando vi chiedete quale sia il vostro scopo.
Io da bambino volevo fare l’astronauta, credevo fermamente che la Terra non fosse il posto adatto a me e l’unico modo per fuggirne era spingermi oltre i limiti del conosciuto per esplorare l’universo. Però, si sa, come direbbe qualcuno molto più saggio di me, è da un pezzo che la maggior parte degli astronauti non va più sulla Luna.
Quando me ne sono fatto una ragione, che sia perché l’infanzia passa velocemente o per la consapevolezza di non poter scappare così lontano, ho deciso che un giorno sarei diventato un commerciante: avrei aperto un negozio, non so di che genere, ed è così che mi sarei guadagnato da vivere. A circa 10 anni non volevo morire sui libri, né tantomeno volevo passare tanti anni a scuola, figurati andare all’università.
Da lì in avanti questo “sogno” non è che mi abbia infiammato più di tanto, forse non è durato neanche un anno o due. La scuola l’ho fatta, e anche con buoni risultati. A un certo punto credevo che la mia strada sarebbe stata quella del cinema: volevo diventare regista. Avevo più o meno 16 anni e l’arroganza di essere un esperto cinefilo. Quest’idea me la sono portata fino alla maggiore età e per un po’, forse, ha alimentato la mia fame.
In realtà non è che ci abbia mai creduto più di tanto. A parte un interesse smodato per le narrazioni filmiche, oltre che per le arti visive in generale, di talento pratico per intraprendere questa strada non ne avevo.
Però, nei primi diciotto anni della mia esistenza, una passione – anzi, per meglio dire un amore spropositato – era chiaro che la avessi: le lingue e le culture straniere. L’avevo coltivata con costanza e consapevolezza, ma mai con la volontà di farne un’ossessione. L’attrazione per il “radicalmente altro” e da ciò che è diverso o sconosciuto, d’altronde, fanno parte di me fin da bambino.
Ok, forse sono partito da troppo lontano, ma era quantomai necessario per farvi entrare parzialmente nella mia testa. E, per farlo al meglio, restringo ulteriormente il campo: la mia fissa è l’inglese. Ma non quello mainstream americano dell’American Dream, delle stelle e strisce, dell’ipermodernità; ciò che mi assilla è la cultura british, quella di Shakespeare, delle città industriali, del Norfolk e della Cornovaglia, così come della diversità gallese e dell’estremo nord scozzese. L’unica eccezione fuori dal confine della Gran Bretagna la faccio per l’Irlanda, ma solo perché stiamo lì.
Per questo mi sono iscritto all’università (scusami Nicola decenne), ho una laurea triennale in lingue e culture straniere, sono in procinto di prendere la specialistica e, last but not least, faccio l’insegnante di inglese.
“Hai trovato la tua strada”, “continua così!”, “di cosa ti lamenti?!”, bla bla bla… Tutto molto bello, direte, e in parte avete ragione, perché sono contento così: faccio il lavoro che vorrei, ho fatto – nella mia ancora acerba carriera – della mia passione un impiego.
La verità è un’altra, e si cela nel lasso di tempo a cui fino a questo punto ho evitato di attribuire il sogno di cui rendervi partecipi. Quello maturo, che mi rode l’anima a ogni momento del mio vivere, che mi fa sentire fuori posto a ogni respiro e che tuttora alimenta ogni sforzo che profondo nel quotidiano.
«[…] the huge peaceful wilderness of outer London, the barges in the miry river, the familiar streets, the posters telling of cricket matches and Royal weddings, the man in bowler hats, the pigeons in Trafalgar Square, the red buses, the blue policemen […]»
Il mio Sogno (con la S maiuscola, sì) è trasferirmi a Londra ed è il mio chiodo fisso da circa 10 anni, prima come desiderio recondito e poi come consapevolezza matura che il mio luogo dell’anima è lì. Le motivazioni non sono di certo economiche, non rincorro alcuna fantasia di diventare l’expat bilionario che ce l’ha fatta; l’ambizione è soltanto una ed è immateriale: anche se forse l’età non gioca più a mio favore, voglio essere un londoner a tutti gli effetti. Certo, adesso sono meno integralista rispetto a qualche anno fa, se dovessi “accontentarmi” di un qualsiasi altro luogo sul suolo britannico ci metterei la firma, prenderei il passaporto, farei la valigia, zaino in spalla e bye bye.
Dovendo mettere tutte le carte sul tavolo e giocare allo scoperto, a dirla tutta una volta l’ho fatto: ho preparato due valigioni pesantissimi, mi sono messo lo zaino in spalla e con un biglietto di sola andata sono partito alla volta di Londra con l’intenzione di passarci un periodo non definito di tempo che fosse proficuamente e spiritualmente soddisfacente per poi migrare verso altri lidi (alias l’Olanda, ma questa è un’altra storia: ciò mi avrebbero consentito di concludere il mio percorso universitario).
In quel frangente, quando mi ero promesso di farmi solo “passare lo sfizio”, avevo mentito a me stesso. Ciò l’ho capito immediatamente quando, con le mie fidate valige e le spalle lussate dal loro peso, ho sceso le scale dell’Underground di Liverpool Street. Una folla di pendolari mi aveva accerchiato, correndo verso e contro di me. Da lontano, nel corridoio che portava alla banchina, un musicista cantava:
«So please please please
Let me, let me, let me
Let me get what I want
[…]»
Io, in quella massa che mi travolgeva, mi sentivo a casa: felice, libero, in pace con me stesso. Mi sono sempre sentito così, prima di allora e dopo quel momento, ogni volta che ho preso la Tube e ogni volta che ne sono riemerso in qualsiasi posto di Londra. La canzone, però, non poteva essere un caso e quelle parole non facevano che darmi un’ulteriore consapevolezza che quella fosse la strada giusta.
Sono rimasto due mesi a Londra, durante l’estate più torrida che l’Inghilterra abbia mai visto, in uno sgabuzzino che chiamavo casa tra Willesden Junction e Harlesden. Un piccolo studio flat di 15 m² che, per quanto possa essere angusto e misero, mi ha visto finalmente superare il blocco dello scrittore. Bastava liberarsi delle catene, essere finalmente in pace con sé stessi, per far sì che potessi mettere nero su bianco le idee che maturavo da tempo e l’ho fatto: tra notti insonni e delle sere senza impegni, sulle pagine si imprimevano pensieri, parole e frasi; ma soprattutto la bozza di quello che doveva essere un romanzo distopico. L’unico lettore (e anche parziale, a dirla tutta), il mio amico italo-brasiliano João. Di tutto ciò restano soltanto pochi frammenti, sopravvissuti alla rabbia e al dolore del rientro; il più importante, la bozza, ormai superstite soltanto nella mia mente.
A un certo punto ho rifatto le valigie per rientrare a Napoli. Ero convinto che l’egoismo di perseguire il mio sogno mi stava togliendo ogni affetto, la famiglia, gli amici, l’amore. La realtà è che quando ho rimesso piede in Italia sono morto due volte: non avevo avuto il coraggio di tener fede al mio sogno e non avevo la forza di ripartire.
Per ricostruire i pezzi ci è voluto un bel po’. Il tempo mi ha insegnato che l’egoismo, quello sano di chi è affamato dal proprio sogno, non toglie affetti o sacrifica relazioni. Bisogna prima rispettare sé stessi avendo riverenza per i propri desideri, nulla deve fermarci dall’intraprendere la nostra strada. Ho deciso di non accontentarmi, perché non è vero che chi si accontenta gode. A farlo si muore dentro, dietro un’apparente felicità. Tra due strade, l’audacia e la paura, bisogna sempre scegliere la prima e rischiare di fare ciò che si desidera.
Presto o tardi, personalmente, rimetterò lo zaino in spalla. Tenterò di nuovo, più forte di prima. Consapevole che sono i sogni a renderci unici, senza di essi non siamo nulla e non facciamo altro che sopravvivere.
C’è chi si accontenta di “sopravvivere” la propria vita in un paese di provincia, vedere sempre le stesse persone e gli stessi luoghi, crogiolarsi nell’amenità dei discorsi bigotti di questi ambienti, aspirare alla notorietà locale e a una ricchezza relativa. Sono fiero delle mie origini e amo la mia terra, ma io voglio essere qualcuno. Non per gli altri, per me stesso, per la mia anima. Io voglio essere ricco. Di vita, di curiosità, di storie, di esperienze. Di sogni, falliti o conseguiti.
E allora…
«… please please please
Let me, let me, let me
Let me get what I want
This time»